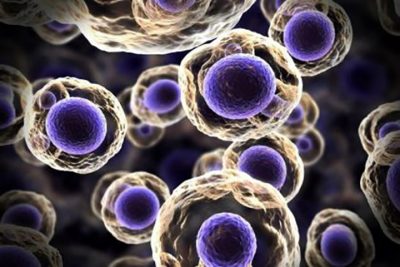L’invecchiamento è il principale fattore di rischio per numerose malattie potenzialmente letali ed è da tempo al centro della ricerca biologica. La riprogrammazione epigenetica, un processo in grado di modulare il destino e l’età cellulare, si è affermata come una promettente frontiera nella medicina rigenerativa e nella scienza della longevità.
La riprogrammazione epigenetica si riferisce alla modifica deliberata dei marcatori epigenetici che regolano l’espressione genica per ripristinare l’età biologica o l’identità di una cellula. A differenza delle mutazioni o dei cambiamenti nella sequenza dell’acido desossiribonucleico (DNA), le modifiche epigenetiche sono reversibili, il che le rende bersagli interessanti per interventi terapeutici correlati all’età.
Epigenetica-Immagine credit public domain.
Negli ultimi anni, la possibilità di invertire l’invecchiamento attraverso tale riprogrammazione ha galvanizzato la ricerca in medicina rigenerativa e nella scienza della longevità. Centrale a questo progresso è l’ipotesi che la perdita o la distorsione delle informazioni epigenetiche determini almeno in parte l’invecchiamento cellulare.
In questo articolo, esaminiamo l’attuale comprensione dei meccanismi alla base della riprogrammazione epigenetica, come questa possa influenzare l’invecchiamento e in che misura possa favorire il ringiovanimento cellulare. Analizziamo inoltre studi chiave, sfide etiche e tecniche e il crescente interesse commerciale per le terapie di inversione dell’invecchiamento.
Che cos’è la riprogrammazione epigenetica?
La riprogrammazione epigenetica comporta il ripristino di marcatori epigenetici, come la metilazione del DNA e le modificazioni istoniche, a uno stato più giovanile. Il concetto ha guadagnato interesse e popolarità scientifica in seguito alla scoperta, premiata con il Nobel, delle cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) da parte di Takahashi e Yamanaka, che hanno dimostrato che le cellule somatiche possono essere riprogrammate in cellule pluripotenti utilizzando quattro fattori di trascrizione, ovvero Oct4, Sox2, Klf4 e c-Myc, noti insieme come fattori OSKM. 3
Questo processo non solo ripristina l’identità cellulare, ma inverte anche i marcatori epigenetici associati all’età.
I meccanismi chiave coinvolti nella riprogrammazione includono:
Metilazione del DNA: aggiunta di gruppi metilici a sequenze specifiche di DNA contenenti una ripetizione lineare di nucleotidi di citosina e guanina (dinucleotidi CpG ). La metilazione del DNA è principalmente coinvolta nel silenziamento dell’espressione genica.
Modifica degli istoni: cambiamenti post-traduzionali alle proteine istoniche che contribuiscono a impacchettare il DNA nei cromosomi. Questi cambiamenti includono metilazione e acetilazione , che influenzano la struttura della cromatina e l’accessibilità genica.
Rimodellamento della cromatina: cambiamenti nel posizionamento dei nucleosomi che alterano significativamente la struttura della cromatina, regolando l’accessibilità dei fattori di trascrizione al DNA.
In che modo i cambiamenti epigenetici influenzano l’invecchiamento?
L’invecchiamento è accompagnato da una progressiva deriva epigenetica, ovvero una divergenza dalla configurazione epigenomica originale di una cellula giovane. Ciò include una metilazione aberrante del DNA, modificazioni istoniche e rimodellamento della cromatina, che portano cumulativamente a un’espressione genica disregolata, a una funzionalità cellulare compromessa e a fenotipi e patologie correlati all’età.
Studi su lieviti, topi ed esseri umani indicano che tali cambiamenti non sono semplicemente correlativi, ma svolgono un ruolo causale nell’invecchiamento. Ad esempio, nei gemelli monozigoti, i profili epigenetici diventano sempre più dissimili con l’età, nonostante il background genetico sia identico. Analogamente, è noto che interventi come la restrizione calorica, che prolungano la durata della vita, influenzano gli stati epigenetici.
Gli scienziati hanno sfruttato questa conoscenza dell’accumulo prevedibile di tag di metilazione del DNA per sviluppare strumenti come l’orologio epigenetico, uno stimatore dell’età biologica .
Una delle versioni più note, l’orologio di Horvath, sviluppato da Steve Horvath nel 2013, utilizza questi modelli di metilazione in più tessuti per calcolare l’età biologica di una persona con notevole precisione.
Studi chiave sull’inversione dell’età tramite riprogrammazione
Esperimenti innovativi hanno dimostrato che la riprogrammazione epigenetica può ripristinare le caratteristiche giovanili dei tessuti invecchiati. Uno studio fondamentale condotto dal laboratorio guidato dal Dott. Juan Carlos Izpisua Belmonte, attualmente direttore del San Diego Institute of Science dell’Altos Lab, ha ulteriormente dimostrato che l’espressione ciclica dei fattori di Yamanaka (OSKM) in un modello murino affetto da invecchiamento accelerato potrebbe prolungare la durata della vita e migliorare i tratti distintivi associati all’invecchiamento senza indurre pluripotenza.
Attivando a intermittenza i fattori OSKM, i ricercatori hanno evitato i rischi di tumorigenesi tipicamente associati alla riprogrammazione continua. I topi trattati hanno mostrato una migliore rigenerazione muscolare, una migliore funzionalità pancreatica e profili epigenetici più giovanili, suggerendo che la riprogrammazione parziale potrebbe essere una strategia praticabile per l’inversione sistemica dell’invecchiamento.
Un altro studio del 2020 condotto da un team di ricerca della Harvard Medical School ha dimostrato che l’espressione dei fattori Oct4, Sox2 e Klf4 (fattori OSK) nelle cellule gangliari della retina del topo ha invertito la metilazione del DNA associata all’età e ha migliorato la funzione visiva.
L’intervento ha richiesto gli enzimi TET1 e TET2 DNA demetilasi (traslocazione dieci-undici), che suggeriscono il ruolo del rimodellamento della metilazione attiva del DNA nel ringiovanimento .
Allo stesso modo, l’espressione ciclica di OSKM in un altro modello ha migliorato la funzione dei tessuti e prolungato la durata della vita, supportando la fattibilità della riprogrammazione parziale in vivo .
I recenti progressi includono anche la riprogrammazione indotta chimicamente. Un altro team di ricerca della Harvard Medical School ha identificato sei cocktail chimici, costituiti da combinazioni di piccole molecole come acido valproico, forskolina e tranilcipromina, in grado di invertire l’invecchiamento trascrittomico nelle cellule umane senza manipolazione genetica, segnando un passo significativo verso la traduzione clinica.1
Sfide etiche e tecniche
Nonostante le sue potenzialità, la riprogrammazione epigenetica si scontra con ostacoli sostanziali. Una delle principali preoccupazioni è il rischio oncogeno associato alla riprogrammazione completa. Mantenere l’identità delle cellule somatiche durante l’induzione del ringiovanimento è una questione critica.
La sovraespressione dei fattori OSMK rischia la dedifferenziazione o la parziale reversione a uno stato pluripotente, che può innescare la tumorigenesi o interrompere la funzione dei tessuti.
Anche il determinismo epigenetico, ovvero il concetto secondo cui l’espressione di tratti e comportamenti è determinata da meccanismi epigenetici e non solo dalla sequenza del DNA, solleva preoccupazioni etiche.
L’idea che le esperienze di vita possano imprimere cambiamenti ereditari mette in discussione i concetti di autonomia personale e complica la tutela della privacy. Vi sono ulteriori preoccupazioni circa l’equo accesso, soprattutto se le terapie di riprogrammazione vengono commercializzate prima che vengano stabiliti standard normativi.
Da un punto di vista tecnico, le sfide includono lo sviluppo di sistemi di distribuzione sicuri ed efficienti per i fattori di riprogrammazione, in particolare in vivo, dove i vettori virali possono comportare rischi di integrazione e reazioni immunitarie.
Sistemi non integrativi come l’acido ribonucleico messaggero (mRNA), le proteine e le nanoparticelle sono in fase di esplorazione, ma richiedono un’ulteriore ottimizzazione per la stabilità e il targeting specifico del tessuto.
Altre sfide tecniche includono la necessità di biomarcatori affidabili per monitorare l’efficacia della riprogrammazione in tempo reale e i potenziali effetti off-target dei cocktail di riprogrammazione, soprattutto nei tessuti eterogenei con firme epigenetiche variabili.
Implicazioni commerciali e longevità delle startup
Il settore biotecnologico si è rapidamente mobilitato per esplorare il potenziale della riprogrammazione epigenetica. Aziende come Altos Labs, Rejuvenate Bio e Life Biosciences stanno investendo massicciamente in piattaforme volte a prolungare la durata della salute e a invertire i danni legati all’età attraverso la terapia genica, le piccole molecole e la biologia sintetica.
Sebbene la maggior parte degli interventi rimanga in fase preclinica, gli investimenti in capitale di rischio e le partnership con le aziende farmaceutiche ne stanno accelerando lo sviluppo. Ad esempio, Rejuvenate Bio ha avviato studi di proof-of-concept per la riprogrammazione mediata da OSK in modelli di malattie cardiovascolari.
Inoltre, Altos Labs ha investito ingenti risorse nella creazione di centri di ricerca per studiare protocolli di riprogrammazione parziale sicuri. Tuttavia, i quadri normativi sono attualmente in ritardo rispetto al ritmo dell’innovazione, rappresentando un ostacolo all’adozione clinica.
Leggi anche: L epigenetica apre le porte a una diagnosi più rapida del cancro
Direzioni future nella terapia epigenetica
La terapia epigenetica è destinata a diventare un pilastro della medicina di precisione. Le tendenze attuali indicano che i progressi nell’epigenomica monocellulare, nell’apprendimento automatico e nella biologia sintetica consentiranno un controllo più preciso dell’epigenoma.
Le aree di interesse della. ricerca futura includono sistemi di distribuzione non integrativi, come mRNA, proteine e nanoparticelle, che possono evitare alterazioni genomiche e riprogrammazioni parziali mirate a tessuti o organi specifici.
Altri ambiti promettenti della terapia epigenetica sono l’identificazione e l’uso di biomarcatori dell’invecchiamento per personalizzare gli interventi, nonché terapie combinate che abbinano modulatori epigenetici a farmaci antinfiammatori e senolitici che eliminano le cellule associate al danno tissutale.
Inoltre, la ricerca in corso sui modulatori epigenetici a piccole molecole potrebbe produrre interventi scalabili e non invasivi.
Tuttavia, la strada verso la traduzione clinica è complessa e costellata da numerose sfide etiche e tecniche. Ciononostante, il ritmo delle scoperte scientifiche nel campo dell’epigenetica e i consistenti investimenti commerciali indicano che le terapie epigenetiche potrebbero presto entrare nel panorama terapeutico.
La capacità di manipolare in modo sicuro ed efficace l’epigenoma offre notevoli speranze al futuro della scienza della longevità.
Fonte: NewsMedical